La tradizione mineraria calabrese
- Elisa Proietti
- 20 mag 2022
- Tempo di lettura: 4 min

La tradizione dei minatori di Calabria è molto antica: il lavoro attraverso cui crebbe e si sviluppò l’arte della costruzione di gallerie prese avvio già nell’antichità, quando l’uomo scoprì l’utilizzo e il valore dei minerali solidi o liquidi.
Quella del minatore è una figura professionale che – se analizzata storicamente – trova radici nell’origine della civiltà, quando l’uomo imparò a costruire le sue spelonche nelle rocce per crearvi dei ripari come abitazioni.
I siti minerari e la localizzazione
Tuttavia, per avere una idea di quanto fosse praticata l’arte estrattiva e lo sfruttamento dei minerali della regione, ci rifacciamo ai risultati del censimento realizzato dal Ministero dell’Ambiente in merito ai siti minerari abbandonati dal 1870 ad oggi. Da questo censimento viene fuori una realtà costituita da ben 60 siti, di cui 29 miniere a cielo aperto e 31 nel sottosuolo. Stando alla tipologia dei minerali, la maggior parte dei siti sono di zolfo, seguito dal feldspati.
Focalizzandoci sulla zona adiacente alla Locride, le aree dove è proliferata la ricerca mineraria in provincia di Reggio Calabria, sono gli antichi siti di Bivongi e Pazzano, per la presenza di minerali di molibdeno.
Proprio quest’ultimo sito, per la storia millenaria che ruota intorno alle miniere di minerali di ferro, ci introduce alla tradizione antichissima dell’attività del cavatore. Tale attività – man mano che si svilupparono le tecniche della perforazione e realizzazione di gallerie - portò alla definizione del moderno minatore.
Cenni storici
Il maggiore periodo di splendore del sistema Minerario metallurgico calabrese, che ruotava intorno al complesso ricadente nel vasto territorio di Stilo e Mongiana, si ebbe tra il 1750 ed il 1860. Nel 1749, Carlo di Borbone, fece pervenire dalla Sassonia e dall’Ungheria un gruppo di tecnici e di esperti per introdurre moderne tecniche e metodologie di scavo delle gallerie e delle miniere. Gli studi furono fruttuosi al punto che, già nel 1753, fervevano i lavori di ammodernamento delle attività estrattive.
Il bacino di lavoratori
La consistenza degli operai in attività nelle variegate gallerie delle miniere e delle saline, se si considera che nel solo comparto di Pazzano nel 1803 risultano impiegati 140 unità, era considerevole. Allargando lo sguardo all'intera regione per lo stesso periodo si può indicare per la presenza di almeno 2.000 minatori.
All’inizio dell' Ottocento, il rilancio borbonico del comparto minerario-metallugico calabrese della Mongiana ne face uno dei maggiori comparti industriali della penisola italiana. Nel 1806, infatti, si puntò al comparto minerario di questa regione per il rilancio economico dello Stato napoletano.
Altra documentazione storica, testimonia l’uso a carattere industriale dell’estrazione di zolfo sin dal periodo postunitario (1870). Vediamone alcuni casi esemplari.
La miniera di Santa Domenica, situata nel Comune di Melissa (KR), nel 1955 occupava 330 operai e cessò ,a produzione nel 1957.
Sempre nel crotonese, un’altra miniera si trovava nel territorio di Strongoli e negli anni ’50 del secolo scorso arrivò ad occupare più di 200 minatori. Infine, tra le maggiori attività minerarie calabresi, è d’obbligo citare la miniera di salgemma di Lungro, in provincia di Cosenza; quest'ultima fu una di quelle rimaste in attività fino al 1976. In termini occupazionali, nel 1880, più di 400 operai di Lungro lavoravano nella miniera, mentre per maggiore sicurezza nel 1881 fu fatto costruire un nuovo pozzo di estrazione ad una profondità di 250 metri, grazie al quale si poté risolvere anche il problema della ventilazione delle quattro gallerie.
Da questa storica esperienza di miniere e gallerie prese corpo l’esperienza del lavoro degli operai edili addetti alla perforazione del sottosuolo di montagne, colline e quant’altro necessario per la realizzazione di gallerie per l’estrazione di minerali, per la realizzazione delle strade ferrate e via via sempre più specializzati.
Rivendicazioni ed emigrazione
Data l’importanza e la diffusione della professione nel territorio regionale, i minatori calabresi furono protagonisti di diverse rivendicazioni. Si tratta delle lotte popolari che hanno contraddistinto il periodo iniziale del ‘900, come quella di San Marco Argentano e di Castrovillari, in provincia di Cosenza, quando i lavoratori insorsero contro i ritardi e la mancata costruzione del tratto ferroviario che portava a Lagonegro; oppure allo sciopero dei 30 minatori della miniera di lignite di Donnici Inferiore (Cs), quando si scioperò per rivendicare la riduzione dell’orario di lavoro da 10 a 8 ore giornaliere.
La chiusura delle miniere coinvolse numerosi paesi del territorio regionale, e portò ad un consistente fenomeno migratorio. Secondo quanto documentato da scritti della CGIL, i paesi da cui proveniva il maggiore numero di minatori erano i seguenti: Petilia Policastro, Cotronei, San Giovanni in Fiore, Laino Borgo, Tortora, Acri, Botricello, Celico, Pizzo Calabro, Crotone, Cosenza, Castrovillari, Luzzi, Montalto Uffugo, Rogliano, Scigliano, Coslosimi, Bocca di Piazza, Serricella, Spezzano Albanese, Spezzano Piccolo, Aprigliano, Locri, Ardore, Piano Lago, Roccabernarda, Cerenzia, Rocca di Neto, Caccuri, Mesoraca, Petronà, Altilia, San Nicola dell’Alto, Belvedere Spinello, Sellia Marina, Gimigliano, Bianchi, Cirò, Attilia Grimaldi, Paola, Gioia Tauro.
La maggior parte dei minatori calabresi dopo la chiusura delle varie attività estrattive è stata utilizzata nei cantieri della TAV.
Ciò che è importante sottolineare è che punto centrale nelle rivendicazioni dei lavoratori di quel periodo fu la lotta ad avere anzitutto un lavoro nel proprio paese, nella propria provincia o quanto meno nella propria regione.
Ripensare ai lavori storici in chiave nuova
La professione del minatore - alla luce di quanto detto pocanzi - non era soltanto quella di un lavoratore che si alienava in questa occupazione per necessità economiche, ma anche quella di un operaio che acquisisce, custodisce ed affina le sue competenze alla luce della storia e delle tradizioni del luogo in cui si trovava.

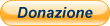
Comments